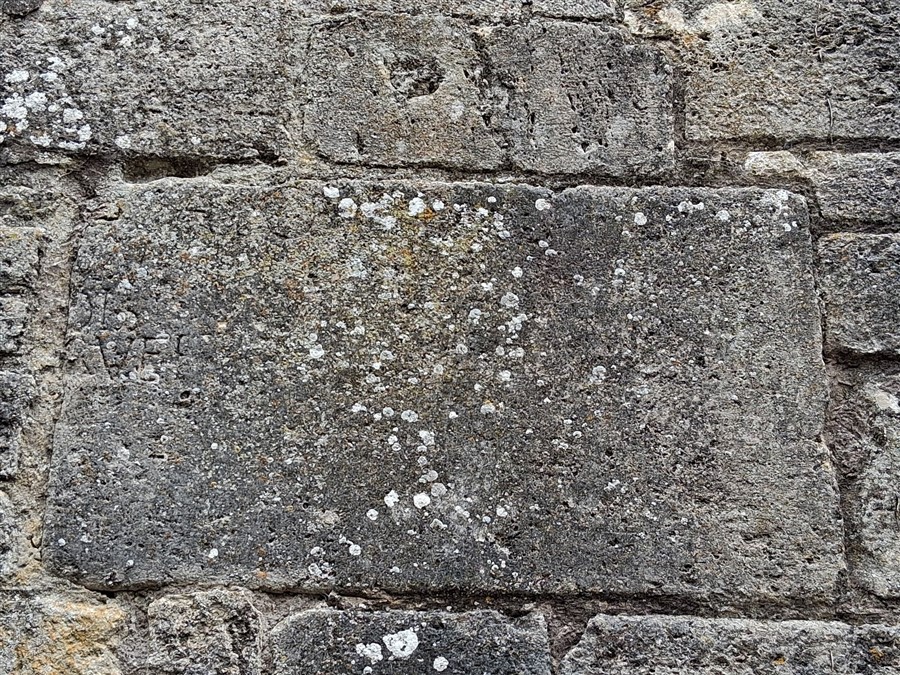Cenni Storici
Uno dei percorsi più interessanti del Parco dei Monti Lucretili scende da Orvinio lungo i sentieri boschivi circostanti alla chiesa di S. Maria in Piano, per finire ad ammirare poi la suggestiva cascata sul vicino Rio Petescia, caratterizzata da acque incredibilmente cristalline.
L’Abbazia benedettina di Santa Maria del Piano (resti) sorge a circa 4 km dal paese, lungo la Via Licinese, nella verde vallata tra i comuni di Orvinio e di Pozzaglia Sabino.
Il complesso benedettino oggi è ridotto a rudere senza coperture e necessita di urgenti interventi di restauro, comprende la chiesa, in pietra calcarea scurita dal tempo, lembi di mura perimetrali e l’allungato profilo della torre campanaria romanica, caratterizzata da più ordini di aperture.
La struttura abbaziale poggia su un promontorio prospiciente la Valle Muzia, che la documentazione archeologica vede abitata privatamente fin dall’epoca romana repubblicana.
La struttura ecclesiastica è probabilmente costruita sui resti di una situazione archeologica complessa, creduta da alcuni un complesso funerario imperiale.
Risale al secolo XI anche se secondo un’antica leggenda sarebbe stato eretto da Carlo Magno nell’VIII o IX secolo per riconoscenza a Dio dopo una battaglia vinta sui Saraceni nella pianura adiacente (quella che dai morti saraceni dette al paese il nome di Canemorto!).
Nella costruzione si è usata comunque una grande quantità di materiali di spoglio da monumenti funerari di età romana.
La documentazione scritta del monastero inizia nel Medioevo con il Regesto farfense; in due documenti del 1026 e 1062 Santa Maria de Putealia compare non come proprietà dell’abbazia di Farfa, ma come elemento confinario a sé stante e già dotato di un nucleo fondiario privato.
Le testimonianze della struttura precedenti a questi documenti rientrano nella tradizione edita dagli studi storico-antiquari locali all’inizio del XVII secolo.
Tali fonti fanno risalire l’origine del complesso abbaziale al IX secolo e attribuiscono la costruzione della chiesa all’imperatore Carlo Magno dopo una vittoriosa battaglia nella pianura adiacente.
L’abbazia crebbe d’importanza nel corso del XII secolo e all’inizio del XIII fu restaurata.
Dopo un periodo di notevole dinamismo e operosità, quando i monaci benedettini legati alla potente abbazia di Farfa estendevano i loro possedimenti su diversi paesi dei dintorni, iniziò la decadenza e sul finire del Medioevo fu abbandonata dai monaci “ob aevi gravitatem et redituum diminutionem“.
A partire dal ‘500 iniziò l’abbandono e il sito era frequentato solo per alcune celebrazioni e le consuetudini rurali.
Un uso temporaneo come cimitero durante l’800, sommato a ripetuti crolli e saccheggi che i vari restauri non sono riusciti a arginare, hanno condotto all’aspetto attuale.
Aspetto
Il monumento, per quanto affascinante e armonicamente inserito nel paesaggio, è ormai privo di molti elementi architettonici impiegati per la sua costruzione e provenienti da resti di edifici romani e medievali della zona (capitelli, stipiti, fregi, bassorilievi).
E’ interessante notare come per questi materiali, in gergo tecnico definiti “di spoglio” perché derivano dallo smantellamento di qualcosa di preesistente, il destino tenda a ripetersi.
Oggi di proprietà dello Stato, fino agli anni ’70 la struttura era del Comune di Orvinio, anche se dal punto di vista amministrativo l’area ricade nel comune di Pozzaglia Sabino.
In tempi remoti, fra gli abitanti dei due paesi sono sorte diverse contese per il possesso dell’abbazia e delle sue terre.
La chiesa
La chiesa, più volte restaurata e rimaneggiata nel tempo, ha pianta a croce latina con navata unica, un tempo coperta a tetto, abside semicircolare sopraelevata, transetto anticamente con volte a crociera e torre campanaria.
La navata era separata dal transetto da quattro grandi archi a sesto leggermente ribassato, con ghiera a conci squadrati, poggianti su tozze semicolonne con capitelli di forme diverse, probabilmente provenienti da materiale di recupero.
L’analisi delle strutture murarie dimostra che la chiesa ha subito nel tempo notevoli trasformazioni. Un sicuro restauro fu eseguito dal presbitero Bartolomeo nel 1219 (v. iscrizione divisa in due formelle posta sotto gli archetti pensili della facciata).
A tale occasione si fa risalire il rosone della facciata, rubato nel 1979, poi, in seguito di un crollo, la facciata fu ricostruita più bassa, utilizzando gli elementi originari.
A seguito di un altro crollo (1953) la Soprintendenza ai monumenti del Lazio ha eseguito tra il 1953 e il 1957 una campagna di restauri con lavori di ricomposizione, di ricostruzione della facciata, di consolidamento del corpo della chiesa e di ripristino della torre campanaria.
La facciata a capanna è del secolo XI e presenta caratteri architettonici e ornamentali affini a quelli della chiesa di S. Vittoria a Monteleone Sabino, nonché aggiunte quattrocentesche (portale).
Il Campanile
La torre campanaria alta circa 20 metri è a pianta quadrata.
Una sottile cornice la divide in una zona inferiore priva di aperture e in una superiore con quattro ordini di finestre secondo la consueta successione monofora, bifora e due piani di trifore. Internamente vi erano solai lignei e scale, come dimostrano i fori per il passaggio delle travi nella muratura, e vi si accedeva solo dai piani superiori del monastero, nel lato a settentrione verso la chiesa.
Il Convento
Il convento, di cui oggi restano tratti di muro, era in stretta connessione con la torre campanaria per la quale rappresentava l’unica via di accesso.
In passato deve aver avuto grande importanza, visti i suoi numerosi possedimenti.
Nel XV secolo lo sappiamo retto da un abate sottoposto al potere vescovile ma autorizzato a percepire le decime, e nel XVIII secolo abitato da un frate dell’Ordine degli Eremitani (Agostiniani).
Nel secolo XIX iniziò la decadenza del convento.
Orvinio
Orvinio (m 840, 400 ab.), alle propaggini settentrionali dei monti Lucretili, si erge sulle pendici dello spartiacque del fiume Turano, su un colle calcareo attorno al suo imponente Castello.
E’ il più alto centro abitato del Parco dei Monti Lucretili e fa parte dei Borghi più belli d’Italia, titolo che si è guadagnato per il suo fascino, le sue casette arroccate e i suoi vicoli.
Il paese conserva tratti della cinta muraria con torri di difesa e alcune tipologie costruttive residenziali di epoca rinascimentale; ha un nucleo storico ordinato e pianeggiante con una via principale, quasi un corso cittadino, che conduce dalla porta di accesso (un grande arco) fino all’interno del borgo medievale e al grande Castello Orsini, rinascimentale con recenti rimaneggiamenti, appartenente ai marchesi Malvezzi-Campeggi.
L’origine dell’antica città di Orvinium (completamente distrutta prima dell’anno mille) è fatta risalire al periodo in cui i Siculi occupavano la Sabina; fu poi ricordata dagli storici romani come centro di fama, dominato da un tempio dedicato alla dea Minerva.
Poi prese il nome di Canemorto, che la leggenda attribuisce a come i soldati di Carlo Magno avrebbero chiamato i saraceni qui uccisi in battaglia nell’817 (“cani morti“, appunto) e che conservò fino al 1863.
Per molti secoli rimase sotto il dominio dei monaci Benedettini di Santa Maria del Piano, poi il borgo risulta sotto l’influenza del comune di Tivoli ed è menzionato negli statuti tiburtini del XIV e XVI sec.
Nel ‘400 fu un possedimento della famiglia Orsini, ceduto nel 1558 ai Tuttavilla, ai Muti nel 1573 e dopo il 1625 ai Borghese, che ne divennero duchi.
Nell’800 Orvinio fece parte dello Stato Pontificio, con sede di Governo e residenza del Governatore.
E’ un luogo dalle vicende storiche movimentate, che conserva l’eleganza di un centro medievale e i ritmi assolutamente lenti di un tempo.
Il centro di Orvinio conserva alcuni tratti visibili delle mura che un tempo la cingevano e passeggiando tra le strade del nucleo residenziale si possono ammirare esempi di abitazioni di epoca rinascimentale.
Nativi di Orvinio sono personaggi come l’incisore settecentesco Girolamo Frezza, il romanziere Virgilio Brocchi, i pittori seicenteschi Ascanio e Vincenzo Manenti; la fama di quest’ultimo è stata recuperata solo agli inizi del ‘900, ma che ai suoi tempi era un artista noto e affermato in tutto il centro Italia, soprattutto presso confraternite e ordini religiosi.
Alcuni suoi affreschi rivestono le pareti della chiesa (ed ex convento francescano) di S. Maria dei Raccomandati (seconda metà del ‘500) nella zona più sopraelevata del borgo, dove ha lavorato anche il padre Ascanio.
Da vedere ancora a Orvinio, la chiesa di San Giacomo (sconsacrata) eretta nel 1614 per volere del barone Giacomo Muti e anch’essa scrigno di prestigiosi dipinti del Manenti.
La parrocchiale di San Nicola di Bari fu edificata nel 1842 su una precedente del XVI secolo.
Il castello Malvezzi Campeggi (sec. XI) è l’attrazione principale di Orvinio; la struttura oggi visibile è frutto di numerosi rimaneggiamenti ordinati dai diversi proprietari che lo possedettero, tra cui gli Orsini che nel Cinquecento lo ampliarono notevolmente; le sue mura di cinta occupano gran parte del centro storico e le sue stanze sono spesso utilizzate per cerimonie e soggiorni, per concessione dei marchesi attuali proprietari.
Al polentone, la polenta locale, è dedicato un festival con due appuntamenti annuali, a gennaio e ad agosto; il cecamariti è un tipo di pasta tradizionale (acqua e farina) fatta in casa, la cui sagra va nel mese di giugno.
Tra le altre prelibatezze le sagne all’aglione o ai porcini.
A ottobre si tiene Enorvinio, manifestazione dedicata ai migliori vini e alle più particolari birre, con focus sui prodotti del territorio e sulle eccellenze delle altre regioni italiane.
Fonti documentative
Cartellonistica Locale
Orvinio, su iborghipiùbelliditalia.it
Nota
Il testo è di Stanislao Fioramonti, le foto sono di Patrizia Magistri; la visita è stata effettuata il 6 giugno 2020.
Alcune foto dell’Abbazia di Santa Maria del Piano sono di Pierluigi Capotondi.
Mappa
Link alle coordinate Abbazia di Santa Maria del Piano: 42.137226 12.956017
Link alle coordinate Orvinio: 42.131854 12.940499